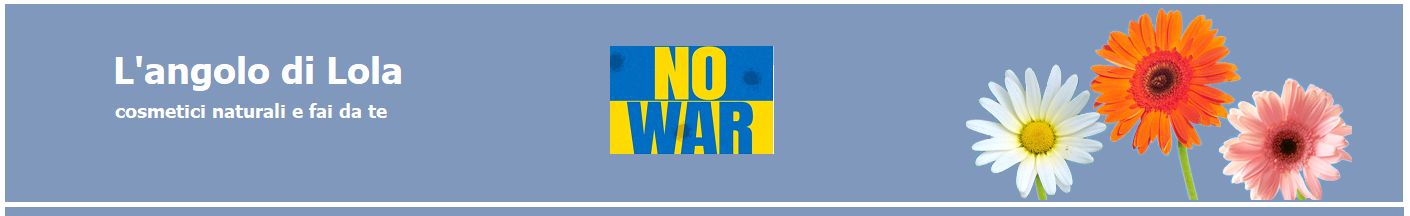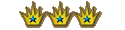fonte: Dizionario di Cosmetologia, Gianni Proserpio - Elena Racchini
IL SOLE
attualmente ci sono tante espressioni che si riferiscono all'abbronzatura e ai prodotti solari in generale.
forse la cosa giusta sia proprio quella di riunirli tutti insieme, per poter avere una visione globale su questo argomento e comprendere meglio alcune funzioni e termini usati.
L'alfabeto vuole che questo termine cosmetico sia il primo della lista e purtroppo è molto poco rappresentativo delle reali funzioni cosmetiche.
L'abbronzatura è in effetti una reazione di difesa dell'epidermide nel cui strato basale hanno appropriata sede le cellule preposte alla produzione di melanina, il pigmento cutaneo di color bruno (o bronzeo) che i melanociti provvedono a biosintetizzare a seguito di uno stimolo combinato fra raggi UV-B, ioni rame e ossigeno.
Abbronzante, riferito ad un cosmetico, è dunque termine improprio essendo il processo di "abbronzatura" un fenomeno esclusivamente biochimico e fisiologico.
La ricerca di un abbronzante esterno è stata ricca di tentativi, di errori e di illusioni.
Si è usato (e si usa tutt' ora) l'estratto del mallo di noce ma lo juglone (naftochinone tipico del noce) si limita a colorare in bruno la superficie epidermica e non ha nulla a che vedere col processo di pigmentazione. Si è usato il beta-carotene, colorante naturale che con l'abbronzatura non ha alcun rapporto (la ingestione di carote o di carotene conduce ad un deposito nell'ipoderma di sostanza colorante ma anche qui i melanociti non sono coinvolti). Si sono usate furocumarine presenti nell'essenza di bergamotto; queste sicuramente abbronzano ma a seguito di un processo fototossico e a tempo stesso citotossico (melanosi Berloque) accompagnato da grave eritema.
Recentemente è stato proposto l'uso di "tirosina attivata".
La tirosina è l'aminoacido su cui interviene l'enzima per produrre melanina. Ammesso che la tirosina esogena giunga nei melanociti e da qui nei melanosomi ( e partecipi quindi al processo di melanizazzione) questa via è oggi l'unica accettabile.
Sotto questo profilo solo i cosmetici contenenti tirosina possono essere definiti "abbronzanti".
Anche in questo caso - come nella voce precedente - il termine è improprio.
In assenza del sole e quindi di raggi UV-B non c'è abbronzatura, intesa come melaninogenesi. Più adatto è caso mai il termine "pigmentazione di superficie senza sole". L'effetto abbronzante esteriore è ottenibile con molecole caratterizzate della presenza del gruppo carbonile che a contatto con le proteine dello strato corneo forma legami con i terminali aminici, legami che conducono alla formazione di un complesso colorato noto come "base di Schiff".
Già è stato citato alla voce Abbronzante lo juglone che presenta due carbonili ed un ossidrile. Il mallo di noce che lo contiene colora di bruno la pelle.
Una analoga molecola, il lawsone presente nell'hennè colora invece di rosso.
Il prodotto più usato per colorare la pelle è il DHA (diidrossiacetone), un derivato ossidato del glicerolo che dispone di due ossidrili e di un carbonile.
A patto che la pelle sia ben sgrassata la colora di bruno per circa una settimana (il tempo che le cellule cornee cadano dalla pelle). Ha il difetto di alterarsi producendo acido acetico, dal poco gradevole odore.
Il termine vuole evidenziare l'aspetto bronzeo che la cute assume a seguito del processo melaninogenetico provocato dai raggi UV-B e del conseguente affioramento della melanina passata dal melanocita alle cellule proprie dell'epidermide.
La pigmentazione epidermica è determinata esclusivamente dai raggi UV-B.
Esiste tuttavia il fenomeno (fenomeno di Meirowsky detto della pigmentazione diretta) che si verifica a seguito dell'irraggiamento con raggi UV-A, ad esempio quelli emessi dalle apposite lampade.
I raggi UV-A sono molto meno energetici dei raggi UV-B e non hanno la capacità di attivare l'enzima tirosinasi e quindi di far produrre melanina alla pelle.
Tuttavia hanno la capacità di accelerare il processo di maturazione e di affioramento di melanina preformata e non ancora trasmessa dai melanociti ai cheratinociti.
L'azione dei raggi UV-A provoca quindi una specie di abbronzatura effimera, accompagnata anche da processi ossidativi nella struttura melanica che concorrono a determinare un rapido iscurimento della pelle.
Il processo avviene, ovviamente, anche sotto il sole: la prima "tintarella" che si forma già al primo giorno di esposizione è dovuta alla componente UV-A dei raggi solari. Nell'arco di 72 ore appare poi la "vera" abbronzatura determinata dai raggi UV-B.
Mentre questi ultimi possiedono sia la capacità di causare eritemi che di produrre la melanogenesi, i raggi UV-A sono la causa sia della tintarella che di possibili reazioni fototossiche che, infine, di danni alle fibre elastiche del derma (invecchiamento prematuro da sole, pelle del marinaio e del contadino).
L'abbronzatura, se esagerata, costituisce sempre un danno per la pelle.
E' questa la definizione più corretta da dare ai prodotti di protezione solare, certamente più logica del fuorviante termine "abbronzante".
Nei prodotti antisolari sono infatti contenute sostanze capaci di filtrare in parte o in toto i raggi UV, prevenendo così le scottature solari.
Quando la dose di filtro è adeguata, il rischio di eritema è ridotto ed il processo melanogenetico dell'abbronzatura può avvenire senza danno.
Per caratterizzare gli antisolari si è preferito il simbolo del SPF (fattore di protezione solare) che indica quanto volte può essere prolungato il livello di minima dose eritematica. SPF 2 significa che il tempo medio di eritema (20 minuti) può essere raddoppiato (40 minuti). I filtri solari autorizzati dalla legge 713 sono riportati nell'allegato V, sezione seconda, parte prima e seconda.
Per ogni filtro è indicata la dose massima impiegabile.
Fino a poco tempo fa era ancora in uso la barbara abitudine di attivare e intensificare l'abbronzatura attraverso l'uso di olio essenziale greggio di bergamotto.
Essendo questo ottenuto per spremitura a freddo, contiene molecole non volatili particolarmente rischiose per la pelle: gli psoraleni o furocumarine. Fra questi il MOP o Bergaptene.
Questa molecola è fototossica nel senso che in presenza dei raggi UV-A provoca una pigmentazione permanente, un forte eritema ed è pure citotossica poiché blocca la timina nel DNA cellulare impedendo i normali processi riproduttivi.
Oggi in luogo degli psoraleni si impiega più semplicemente tirosina attivata da vitamina B2 (lattoflavina) o da ATP (adenosin trifosfato) per favorire la penetrazione nel melanocita. La tirosina è l'amminoacido su cui agisce la tirosinasi per trasformarla in dopachinone, molecola che poi si trasforma ulteriormente nel pigmento indolico melanina. Si tratta di una azione cosmetica senza rischio in quanto avviene esclusivamente un apporto esogeno di tirosina che va a sommarsi a quella presente nel melanosoma.
Il sistema sembra funzionare bene e l'attivazione-intensificazione dell'abbronzatura è un fenomeno visibile e constatabile.
Entrambe le espressioni sono improprie in quanto non è coinvolta la cellula melanica né la melanina.
Si tratta più semplicemente di una reazione colorimetrica tra le proteine dello strato corneo e molecole aventi nella loro struttura un gruppo carbonile = CO.
In natura si conosce lo juglone, presente nel mallo di noce (Juglans regia) che steso sulla pelle la colora in bruno.
Un prodotto di sintesi molto usato è il diidrossiacetone ottenuto per ossidazione della glicerina, che colora in bruno la pelle anche in assenza di sole.
La pigmentazione superficiale della pelle è di breve durata, il tempo cioè della desquamazione dello strato corneo (da 7 a 15 giorni).
Essendo sostanze ad azione di superficie operanti su cellule morte, non pongono problema di tossicità.
Il DHA (diidrossiacetone) ha solo il difetto di alterarsi nel tempo liberando un poco gradevole odore di aceto.
Al termine dell'esposizione solare, dopo la doccia di rito, è utile l'applicazione di una emulsione o di un gel doposole cui sono affidate funzionalità lenitive, idratanti e antiarrossamento, per provvedere a rinfrescare la pelle arsa dal troppo sole. Chiaramente il doposole cosmetico non è adatto a riparare i danni da eritemi per i quali occorre ricorrere a medicamenti farmaceutici. Esso contiene NMF, estratti vegetali, bisabololo, pantenolo, allantoina, acido glicirretico.
Marinai e contadini che restano per mesi ed anni esposti al sole assumono con tempo quella che appunto è definita pelle del marinaio o del contadino. Una pelle che ha perso quasi del tutto la sua elsticità. Ciò è dovuto al fatto che i raggi UV-A del sole penetrano nel derma ove causano una progressiva degradazione dei legami desmosinici, in cui risiede la capacità della risposta elastica della pelle. Il fenomeno è appunto definito come elastosi solare ed è osservabile anche in chi resta a lungo al sole alla ricerca di una abbronzatura estrema.
Latti e creme protettivi per l'esposizione solare costituiscono altrettante importanti voci della tecnica cosmetica, ove il formulatore dà il meglio di sé. Le emulsioni A/O, A/S, O/A (queste ultime anche nella versione idroresistente grazie alla presenza di resine filmogene idrofobe) occupano una posizione primaria nel settore cosmetologico anche se il consumatore spesso chiede ai solari prestazioni diverse da quelle che in realtà questi devono offrire.
Non per nulla l'utente chiede un' "abbronzante" (cioè un trattamento estetico) e tende a dimenticare che specie nei primi tre giorni di sole è invece essenziale proteggere la pelle con un solare ad alto fattore protettivo dai raggi UV-B e nei giorni successivi è utile applicare un solare contenente filtro UV-A per prevenire l'invecchiamento prematuro della pelle.
Ovviamente, oltre ai solari con filtro UV-B e UV-A, esistono anche gli intensificatori di abbronzatura a base di tirosina ma questi vanno usati solo dopo che la pelle è stata protetta con un solare a SPF elevato.
Il tecnico prepara anche (ma con scarsa soddisfazione professionale), i cosiddetti pigmentanti senza sole a base di diidrossiacetone (che colorano la pelle in superficie per alcuni giorni). Questa preparazioni non meritano comunque la definizione di prodotti solari. Solari restano soprattutto quelli che proteggono dagli eritemi dei raggi UV-B e dalle fotosensibilizzazioni e dalle elastosi dei raggi UV-A.
Termine più corretto di quello abitualmente usato (scottatura) in quanto il danno cutaneo è causato dei raggi UV-B che sono raggi freddi.
Si ritiene che l'eritema sia la conclusione visibile di una serie di reazioni di tipo immunitario messe in atto dalla pelle e che si concludono con la forma infiammatoria più o meno intensa che ben conosciamo.
Sembra che all'inizio del fenomeno vi sia una trasformazione indotta dai raggi UV-B sulla struttura dell'aminoacido istidina presente nella epidermide. Mentre una parte della istidina viene deaminata con formazione di acido urocanico (prima forma di schermo anti UV attuata dall'epidermide) un'altra quota viene decarbossilata con produzione di istamina.
L'istamina liberata si trasferisce nel derma ove viene coinvolto l'intero sistema di difesa immunitaria della pelle, con formazione di prostaglandine e di avvio del processo infiammatorio. Questo appare entro poche ore dall'irraggiamento UV ed è proporzionale, nella sua intensità, alla quantità di raggi UV che hanno raggiunto l'epidermide.
La difesa melanica si manifesta solo successivamente, dopo circa 72 ore.
Sono così definite dalla legge 713 (allegato V, sezione II) le sostanze in grado di estinguere i raggi UV (UV-A, UV-B o entrambi) consentendo quindi la prevenzione dall'eritema solare, di reazioni fotosensibilizzanti e - nel caso dei filtri UV-A - di prevenire il "photoaging" cioè il prematuro invecchiamento della pelle causato dai raggi UV-A.
I filtri solari consentiti dalla legge sono molecole per lo più di natura aromatica. Fra i più usati, gli esteri dell'acido p-amino benzoico, dell'acido p-metossicinnamico e dell'acido salicilico.
La lista dei filtri UV ammessi comprende anche derivati del dibenzilidencanfora, alcuni benzofenoni, derivati del dibenzoilmetano e, fra i più recenti, l'ottiltriazone.
In presenza di irraggiamento da UV-A talune molecole presenti in preparati farmaceutici o cosmetici possono trasformarsi in agenti allergizzanti. Ne consegue una reazione fotoallergica che si manifesta in forma di eritema con eczema e prurito.
Corrisponde all'applicazione, prima dell'esposizione solare, di un preparato contenente sostanze in grado di estinguere le radiazioni UV incidenti.
La presenza di filtri UV consente di evitare o comunque di ridurre i rischi di eritema solare.
Talune molecole in presenza di raggi UV-A possono determinare reazioni fotoallergiche o fototossiche.
L'assieme di queste reazioni cutanee prende il nome di fotosensibilizzazione.
Mentre la fotoallergia è costituita da una razione di tipo immunitario della pelle alla presenza contemporanea di raggi UV-A e di fotoallergene, la fototossicità è una vera e propria reazione irritativa con implicazioni tossicologiche. Un esempio di razione fototossica è quella causata dalle furocumarina in presenza di UV-A. Si verifica sia un fatto eritematico che un blocco della riproduzione cellulare a seguito della dimerizzazione della timina.
Fino a pochi anni or sono l'unico mezzo usato, con molti rischi, per intensificate l'abbronzatura era costituito dall'essenza grezza di bergamotto in cui sono contenute furocumarine (note anche col nome di psoraleni).
Queste molecole determinano un incremento della pigmentazione ma causano spesso macchie pigmentarie indelebili, sono fototossiche e per di più citotossiche in quanto bloccano l'attività del DNA cellulare. Al loro posto si usa oggi tirosina attivata con vitamina B2 e ATP.
Pigmento, chimicamente di natura indolica, altamente polimerizzato, che si forma nel melanocita a partire da tirosina sotto l'azione di tirosinasi e poi di ossigeno.
Esistono due varietà di melanina, la eumelanina, stabile, di color bruno e la feomelanina, poco stabile, di colore rossastro. In assenza (genetica) di tirosinasi non si ha formazione di melanina, come nel caso degli albini.
Cellula migrata dalla cresta neurale in epoca embriofetale e che si colloca a livello dello strato basale dell'epidermide.
E' caratterizzata da numerosi "dendriti" che si prolungano fra le cellule proprie dell'epidermide.
I corpi entro cui si forma la melanina - i melanosomi - man mano che "maturano" migrano verso la zona distale dei dentriti e poi sotto l'influenza dei raggi UV passano per citocrinina entro ii cheratinociti ove si dispongono a cappuccio sul nucleo cellulare.
La formazione di melanina prende avvio dalla presenza concomitante, nel melanocita, di tirosinasi, ossigeno, ioni Rame e raggi UV.
La tirosina, non appena viene resa disponibile la tirosinasi, subisce una progressiva modifica poi completata dall'ossigeno, sino a dar luogo ad un polimero altamente colorato, detto melanina.
La melanogenesi costituisce una forma di difesa delle cellule epidermiche, attuata dal melanocita.
L'usanza di spalmarsi l'olio protettivo durante l'esposizione al sole nasce sia da precedenti storici (gli antichi egizi impiegavano olio di ricino) sia dalla moda - tuttora viva - di usare estratti oleosi di mallo di noce per conseguire l'abbronzatura più intensa. Ed in effetti l'olio solare più usato è quello con poco filtro e con tanto estratto di mallo di noce, spesso accompagnato da altri estratti vegetali oleosi (iperico, calendola, camomilla). La tendenza più recente è quella l'olio meno untuoso, sostituendo l'olio minerale od i trigliceridi con una parte di ciclosiliconi che sono oli leggeri, volatili e per nulla untuosi.
Non mancano, ovviamente, anche gli oli supergrassi per i patiti dell'abbronzatura lucente. In tal caso prevalgono la vaselina e gli oli vegetali.
La componente colorata fondamentale dell'epidermide è quella melanica.
La melanina è un polimero di natura indolica che si forma a partire dalla tirosina (pidrossi-fenilalalina), aminoacido presente nei melanosomi, tipiche vesciche del melanocita (che è una cellula preposta alla pigmentazione cutanea). Modifiche enzimatiche e chimico-ossidative trasformano progressivamente la tirosina in dopachinone e in dolochinone dalla cui polimerizzazione deriva poi il pigmento melanico.
Questo è di norma bruno (eumelanina) ma talvolta è rosso per inserimento di cisteina (feomelanina).
Scopo fisiologico della pigmentazione cutanea è quello di creare un filtro protettivo a difesa del nucleo delle cellule epidermiche, nucleo che è molto sensibile alle radiazioni ultraviolette; che la pigmentazione cutanea costituisca poi l'ambita abbronzatura è una pura coincidenza fra le esigenze fisiologiche e manie estetiche.
L'emissione di radiazioni da parte del sole comprende sia radiazioni di natura corpuscolare quali i raggi alfa (costituiti da nuclei di elio) ed i raggi beta (costituiti da elettroni) sia radiazioni di natura elettromagnetica.
Sono onde elettromagnetiche i raggi gamma, i raggi X, i raggi UV, i raggi luminosi, i raggi IR, le onde hertziane. Queste vibrazioni elettromagnetiche sono caratterizzate dalla "lunghezza d'onda" che viene oggi espressa in nm (nanometri) mentre un tempo era data in Å (Ångstrom) 1 nm = 10 Å.
I raggi gamma hanno lunghezza d'onda fra 0,001 e 0,01 nm
I raggi X hanno lunghezza d'onda fra 0,01 e 1 nm
I raggi UV-C hanno lunghezza d'onda fra 100 e 280 nm
I raggi UV-B hanno lunghezza d'onda fra 280 e 320 nm
I raggi UV-A hanno lunghezza d'onda fra 320 e 400 nm
I raggi luminosi hanno lunghezza d'onda fra 400 e 800 nm
I raggi IR hanno lunghezza d'onda fra 800 e 1.500 nm
oltre i 1.500 nm si collocano le onde hertziane, radio e sonore. Sulla terra giungono radiazioni solari comprese fra 280 e 1000 nm. Le restanti sono filtrate o dalle ionosfere o dalla atmosfera.
Il sole emette tutta una serie di radiazioni elettromagnetiche che vanno dai raggi gamma ai raggi X, dai raggi Roentgen ai raggi UV, dai raggi visibili ai raggi IR.
Fra tutte queste radiazioni quelle che costituiscono il maggior interesse cosmetico sono le UV (100-400) nm. In particolare sulla terra giungono i raggi UV-B (280-320 nm) e i raggi UV-B (320-400 nm).
Poiché queste radiazioni hanno sulla pelle determinati effetti, la cosmesi utilizza appositi filtri UV-B e UV-A, vale a dire sostanze in grado di estinguere selettivamente tali radiazioni. Poiché le radiazioni UV-B sono particolarmente insidiose nei primi 3 giorni di esposizione solare, si utilizzano il tale periodo prodotti cosmetici contenenti dosi appropriate di filtri UV-B capaci di estinguere dal 50 al 95% i raggi incidenti riducendo così il rischio di eritema.
Quando la pelle ha reagito con adeguata produzione di melanina si presenta il problema di bloccare i raggi UV-A specie se l'esposizione solare è prolungata nel tempo. Si usano allo scopo filtri specifici degli UV-A che consentono di evitare i rischi del photo-aging e quelli di reazioni fotosensibilizzanti.
Lo spettro solare, cioè l'assieme di radiazioni emesse dalla nostra stella, comprende:
- radiazioni invisibili, fredde ma energetiche (UV);
- radiazioni visibili-luminose (la luce bianca);
- radiazioni invisibili, calde, poco energetiche (IR).
A loro volta queste radiazioni sono frazionabili in più gruppi a seconda della lunghezza d'onda. E come la luce visibile (400-800 nm) è frazionabile nei 7 colori dell'iride (viola, indaco, blu, verde, giallo, arancio, rosso) così anche gli UV e gli IR sono separabili in vari gruppi.
Gli UV hanno lunghezze d'onda comprese fra 100 e 400 nm e si distinguono in base alla loro carica energetica in:
- UV-C (100-280 nm) molto energetici, letali per le cellule vegetali ed animali
- UV-B (280-320 nm) energetici, non più letali ma causa di eritema. La pelle si difende con produzione di melanina e di un più spesso strato di cellule epidermiche
- UV-A (320-400 nm) poco energetici ma più penetranti. Provocano la "tintarella immediata" facendo affiorare la melanina, causando elastosi e rilassamento del derma e, in presenza di certe sostanze di fotosensibilizzazione.
RAGGI UV-A (A sta per alta lunghezza d'onda)
Questi raggi costituiscono la quota terminale degli ultravioletti (280-400 nm) che confina con lo spettro dei raggi visibili (400-800 nm).
Nettamente meno energetici dei raggi UV-B ma percentualmente più abbondanti, i raggi UV-A sono anche molto più penetranti e possono giungere sino al derma profondo.
Tre sono gli effetti caratteristici dei raggi UV-A, due dei quali sicuramente negativi.
Il primo effetto, il più appariscente, è il processo di richiamo in superficie della melanina già presente nell'epidermide (fenomeno di Meirowsky). Questa prerogativa è ampiamente sfruttata attraverso le lampade UV-A dei solarium.
Il secondo effetto, che si manifesta per esposizione continuata (pelle del marinaio e del contadino)è quello distruttivo sulle fibre elastiche del derma con conseguente photo-aging cioè invecchiamento prematuro da continuata esposizione agli UV-A.
Pure negativo è il terzo effetto collegato all'azione dei raggi UV-Ache rendono fotosensibilizzanti talune sostanze (furocurmarine del bergamotto, clorpromazina, sulfamidici, ecc.) e che si traduce in eritemi e macchie persistenti nella pelle.
RAGGI UV-B (B sta per bassa lunghezza d'onda)
I raggi UV-Bcostituiscono solo una piccola zona dell'UV (da 280 a 320 nm) ma sono di primario interesse sul piano dermofisiologico e cosmetico in quanto è alla loro carica energetica che sono dovuti i fenomeni dell'eritema solare e dell'abbronzatura. Poco penetranti, i raggi UV-B scaricano interamente nell'epidermide la loro energia.
Questa interviene in modo multiforme sull'epidermide, provocando anzitutto la degradazione dell'istidina con liberazione sia di acido urocanico (filtro naturale UV-B e prima forma di autodifesa della pelle dai raggi UV-B) sia di istamina la quale avvia un processo infiammatorio di difesa immunitaria che si conclude con l'eritema.
L'energia degli UV-B libera successivamente l'enzima tirosinasi contenuto nei melanociti e determina per conseguenza il processo di melanizzazione della epidermide. Mentre la risposta eritematica avviene entro 12 ore dall'esposizione solare l'affioramento di melanina (e quindi la formazione di una difesa sicura del nucleo cellulare) si verifica entro 48-72 ore.
RAGGI UV-C
C sta per "corti", vale a dire raggi a bassissima lunghezza d'onda. Si usa comprendere la zona dell'UV-C fra 100 e 280 nm. Al di sotto dei 100 nm stanno i raggi Roentgen e i raggi X, al di sopra i raggi UV-B (280-320) e gli UV-A (320-400).
I raggi UV-C più corti reagiscono con l'ossigeno atmosferico provocando la formazione di ozono (e della relativa "fascia"). L'ozono provvede poi a distruggere i rimanenti raggi UV-A più lunghi, sicché attraverso la fascia di ozono, creata dagli UV-A cortissimi e dall'ossigeno, passano solo le radiazioni con lunghezza d'onda superiore ai 280 nm.
Superfluo ricordare che i raggi UV-C per la loro elevata energia, risultano letali per le cellule viventi (vegetali e animali) e che è la provvidenziale fascia di ozono a consentire il normale svolgersi della vita sul pianeta terra. Detto per inciso, i cosmetici reclamizzati come contenenti filtri UV-C non hanno alcuna giustificazione logica. Per ora di raggi UV-C sulle terra ancora non ne arrivano.
SCHERMANTE UV
Nella pelle è presente l'aminoacido istidina che, sotto l'effetto dei raggi UV, si deamina formando l'acido urocanico (o imidazolacrilico). Questo ha inizialmente struttura trans che diviene cis a contatto con raggi i UV. Il passaggio di configurazione utilizza l'energia dei raggi UV che vengono così degradati a radiazioni di più alta lunghezza d'onda e meno energetiche. Sulla base di quanto avviene sulla pelle, l'uovo ha sintetizzato molecole (per lo più di natura aromatica) dette sostanze schermanti UV che estinguono i raggi energetici dell'UV trasformandoli in raggi meno energetici.
Le strutture più utilizzate sono quelle degli esteri dell'acido salicilico, dell'acido p-amino-benzoico e dell'acido cinnamico.
Tutti i filtri UV (sia UV-B che UV-A) sono soggetti a norme di legge. L'allegato V sezione seconda della legge 713 sui cosmetici riporta i filtri consentiti. Oltre all'acido urocanico esistono anche altre sostanze naturali (non comprese nella lista legislativa) che possiedono proprietà filtranti: ad es. gli antrachinoni dell'aloe (UV-B), il gamma orizanolo dell'olio di crusca di riso (UV-A) l'estratto di seppia (UV-A).
SCHERMO TOTALE
Quando si intende estinguere sia la radiazione UV-B che quella UV-A si ricorre allo schermo totale. Il preparato deve non solo contenere entrambi i filtri ma deve contenerli in dose tale da assicurare una estinzione pressoché completa. Si utilizzano schermi totali in alta montagna ed in mare aperto, al fine di evitare eritemi causati dalla permanenza prolungata in condizioni di pieno sole.
SOLARE (prodotto)
Solare (o antisolare) è definizione più corretta di abbronzante quale descrizione di un preparato destinato ad evitare l'eritema ad a consentire quindi una tintarella senza problemi.
Tuttavia il settore dei "solari" è oggi inflazionato da "pre-sole attivatori" "intensificatori di abbronzatura" "conservatori di abbronzatura" sicché l'esatta dizione per un vero solare dovrebbe essere "solare filtrante" per indicare che contiene filtri selettivi dei raggi UV al fine di una abbronzatura senza eritemi.
I "solari" possono essere realizzati nelle più svariate forme chimico-fisiche: oli, unguenti, creme e latti A/O (od A/S), creme e latti O/A, geli acquosi sino a semplici soluzioni acquose contenenti filtri idrosolubili.
SPF (Sunburn Ptotection Factor) - Fattore di Protezione Solare
L'SPF è un numero che indica la capacità protettiva di un prodotto solare nei confronti delle radiazioni UVB. Nell'Unione Europea è attualmente in uso il Metodo Internazionale COLIPA/JCIA/CTFA-SA 2006 che stabilisce il metodo per determinare l'SPF (Sunburn Ptotection Factor). L'SPF indica di quanto l'applicazione di un prodotto solare può prolungare, rispetto alla cute non protetta, il tempo di esposizione al sole prima della comparsa di un eritema. Per esempio, se il tempo di eritema individuale è di 5 minuti, un prodotto con SPF di 10 consente un'esposizione solare pari a 50 minuti (5x10) prima della comparsa dell'eritema.
Secondo le nuove disposizioni, valori di SPF compresi tra 6 e 10 verranno indicati in etichetta come "Bassa protezione"; SPF 15-20-25 come "Media protezione"; SPF 30-50 come "Alta protezione", SPF 50+ come "Protezione molto alta".
Per valori di SPF inferiori a 6 un prodotto solare divrà essere commercializzato come "abbronzante" e non potrà vantare una protezione solare. Un prodotto solare dovrà garantire una protezione UVA e UVB con una protezione minima UVA pari o superiore ad 1/3 di quella UVB.